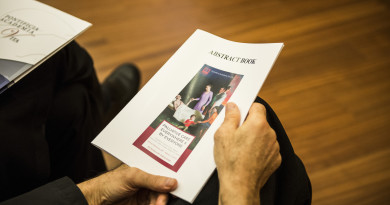Evangelium Vitae, 30 anni. Riflessione di don Gabriele Mangiarotti
(Fonte: prolifeinsieme.it)
Evangelium Vitae: l’attualità di una enciclica. Don Gabriele Mangiarotti a Radio Maria.
Vorrei partire da un bellissimo testo che ci illumina come cristiani cattolici, ci spiega perché abbiamo questo incredibile dono che è la nostra fede che il magistero ci permette di cogliere almeno in parte, nella sua grandezza.
Lumen Gentium 36
Così Cristo per mezzo dei membri della Chiesa illuminerà sempre di più l’intera società umana con la sua luce che salva.
Inoltre i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni del mondo, se ve ne siano che provocano al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l’esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e le opere umane. In questo modo il campo del mondo si trova meglio preparato per accogliere il seme della parola divina, e insieme le porte della Chiesa si aprono più larghe, per permettere che l’annunzio della pace entri nel mondo.
Per l’economia stessa della salvezza imparino i fedeli a ben distinguere tra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto membri della Chiesa, e quelli che competono loro in quanto membri della società umana, cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche nelle cose temporali, può essere sottratta al comando di Dio. Nel nostro tempo è sommamente necessario che questa distinzione e questa armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire dei fedeli, affinché la missione della Chiesa possa più pienamente rispondere alle particolari condizioni del mondo moderno. Come infatti si deve riconoscere che la città terrena, legittimamente dedicata alle cure secolari, è retta da propri principi, così a ragione è rigettata l’infausta dottrina che pretende di costruire la società senza alcuna considerazione per la religione e impugna ed elimina la libertà religiosa dei cittadini. (Lumen Gentium, 36)
Apostolicam Actuositatem 5
5. L’opera della redenzione di Cristo ha per natura sua come fine la salvezza degli uomini, però abbraccia pure il rinnovamento di tutto l’ordine temporale. Di conseguenza la missione della Chiesa non mira soltanto a portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche ad animare e perfezionare l’ordine temporale con lo spirito evangelico. I laici, dunque, svolgendo tale missione della Chiesa, esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell’ordine spirituale e in quello temporale. Questi ordini, sebbene siano distinti, tuttavia sono così legati nell’unico disegno divino, che Dio stesso intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo per formare una creazione nuova: in modo iniziale sulla terra, in modo perfetto alla fine del tempo. Nell’uno e nell’altro ordine il laico, che è simultaneamente membro del popolo di Dio e della città degli uomini, deve continuamente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana.
Enciclica Evangelium Vitae
Il 25 marzo 1995 s. Giovanni Paolo II pubblicava questa enciclica, sul valore e l’inviolabilità della vita umana. Sono passati 30 anni, ma la sua attualità permane e deve ancora venire riscoperta, in un approfondimento che ne colga l’intenzione e i singoli passaggi, di proposta e di giudizio.
La vita umana, dal suo inizio, è anche oggi minacciata, oggi ancora più di ieri, e all’orizzonte la tragedia dell’eutanasia non cessa di portare i suoi frutti malvagi.
Il testo magisteriale del grande papa si comprende adeguatamente se lo si inserisce nel contesto del suo ricco pensiero.
Cerchiamo di scoprire i fattori fondamentali, le categorie più importanti e determinanti per raccogliere e proseguire il suo cammino in difesa della vita, la vita di ogni uomo sulla terra.
Quando inizia il suo pontificato, s. Giovanni Paolo II esordisce con l’invito a rimettere al centro della vita, della cultura, della politica, dell’educazione Cristo, che chiamerà «centro del cosmo e della storia». Per chi ha vissuto quei momenti quella è stata come una scossa salutare e commovente, al punto che tutti ci siamo sentiti interpellati e spronati a una avventura che, per la maggior parte di noi, ha ancora la sua forza propulsiva.
“Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo!”
«Fratelli e Sorelle!
Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! [questo grido iniziale, che riprende le parole con cui Cristo si presenta ai discepoli la notte di Pasqua, segna già l’attitudine fondamentale del suo magistero, in un tempo che, dopo le speranze suscitate dal Concilio Vaticano II, sembravano oramai illanguidire o spegnersi – pensiamo alle parole accorate di Paolo VI sul fumo di satana presente anche nella Chiesa]
Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera!
Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo [e qui notiamo l’orizzonte universale cui ci apre Giovanni Paolo, in un’epoca, la nostra, in cui, nella insistente affermazione della «fine della cristianità», non si comprende più l’invito di Gesù di «andare in tutto il mondo per fare discepole tutte le genti»]. Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!
Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.»
Ma perché non dobbiamo avere paura? E non solo per l’invito di Gesù ai suoi discepoli?
Il Papa ci ricorda – e qui dobbiamo ritrovare la fierezza della nostra fede – il significato profondo della buona novella, perché solo in Cristo l’uomo ritrova pienamente se stesso.
Nel paragrafo 10 della sua prima Enciclica, la Redemptor hominis, così leggiamo (e notiamo che questa viene ritenuta la «dimensione umana del mistero della redenzione» – appunto, «dimensione umana»):
L’uomo non può vivere senza amore
«L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E perciò appunto Cristo Redentore – come è stato già detto – rivela pienamente l’uomo all’uomo stesso. Questa è – se così è lecito esprimersi – la dimensione umana del mistero della Redenzione. In questa dimensione l’uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua umanità. […] L’uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo – non soltanto secondo immediati, parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere – deve, con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto se stesso, deve «appropriarsi» ed assimilare tutta la realtà dell’Incarnazione e della Redenzione per ritrovare se stesso. Se in lui si attua questo profondo processo, allora egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso. Quale valore deve avere l’uomo davanti agli occhi del Creatore se «ha meritato di avere un tanto nobile e grande Redentore», se «Dio ha dato il suo Figlio», affinché egli, l’uomo, «non muoia, ma abbia la vita eterna».
In realtà, quel profondo stupore riguardo al valore ed alla dignità dell’uomo si chiama Vangelo, cioè la Buona Novella. Si chiama anche Cristianesimo. Questo stupore giustifica la missione della Chiesa nel mondo, anche, e forse di più ancora, “nel mondo contemporaneo”».
La fede deve diventare cultura
Questa convinzione del Papa lo porta ad affermare che proprio questa fede deve diventare cultura, deve sostenere un giudizio di verità sull’uomo e sul mondo, deve diventare fondamento di una esperienza di umanità concreta che incontri ogni uomo. Nella certezza che questa stessa cultura tocca il cuore di ogni uomo per la sua corrispondenza al cuore.
«La sintesi fra cultura e fede non è solo una esigenza della cultura, ma anche della fede. […] Se, infatti, è vero che la fede non si identifica con nessuna cultura ed è indipendente rispetto a tutte le culture, non è meno vero che, proprio per questo, la fede è chiamata ad ispirare, ad impregnare ogni cultura. È tutto l’uomo, nella concretezza della sua esistenza quotidiana, che è salvato in Cristo ed è, perciò, tutto l’uomo che deve realizzarsi in Cristo. Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta.»
E tutto questo nella consapevolezza che è proprio la cultura che sostiene il cammino dell’uomo. E qui riusciamo a capire la contrapposizione, che sarà evidente nel corso di tutta l’Enciclica, tra la cultura della vita e la cultura della morte.
«Io sono figlio di una nazione, che ha vissuto le più grandi esperienze della storia, che i suoi vicini hanno condannato a morte a più riprese, ma che è sopravvissuta e che è rimasta se stessa. Essa ha conservato la sua identità ed ha conservato, nonostante le spartizioni e le occupazioni straniere, la sua sovranità nazionale, non appoggiandosi sulle risorse della forza fisica, ma unicamente appoggiandosi sulla sua cultura…»
Quanto affermato nel messaggio di Natale del 1978 mette a tema la preoccupazione e l’interesse di Giovanni Paolo II e che darà tutta la sua forza all’Enciclica sulla vita. È perché l’uomo ha un valore infinito che è giusto rispettarlo sempre, e testimoniare questo impegno anche là dove la mentalità e la politica non sanno arrivare:
“Natale è la festa dell’uomo “
«Questo messaggio lo rivolgo ad ogni uomo; all’uomo; all’uomo, nella sua umanità. Natale è la festa dell’uomo. Nasce l’Uomo. Uno dei miliardi di uomini che sono nati, nascono e nasceranno sulla terra. L’uomo, un elemento componente della grande statistica. Non a caso Gesù è venuto al mondo nel periodo del censimento; quando un imperatore romano voleva sapere quanti sudditi contasse il suo paese. L’uomo, oggetto del calcolo, considerato sotto la categoria della quantità; uno fra miliardi. E nello stesso tempo, uno, unico e irripetibile. Se noi celebriamo così solennemente la nascita di Gesù, lo facciamo per testimoniare che ogni uomo è qualcuno, unico e irripetibile. Se le nostre statistiche umane, le catalogazioni umane, gli umani sistemi politici, economici e sociali, le semplici umane possibilità non riescono ad assicurare all’uomo che egli possa nascere, esistere e operare come un unico e irripetibile, allora tutto ciò glielo assicura Iddio. Per lui e di fronte a lui, l’uomo è sempre unico e irripetibile; qualcuno eternamente ideato ed eternamente prescelto; qualcuno chiamato e denominato con il proprio nome.»
Che cos’è una Enciclica? E quale il suo valore e il suo scopo?
Dalla AI: «L’enciclica papale è una lettera circolare inviata dal Papa alle chiese particolari della Chiesa cattolica, ai vescovi, al clero e ai fedeli. Questi documenti trattano argomenti di grande importanza per la dottrina della Chiesa e la vita dei cattolici. Le encicliche sono uno strumento fondamentale attraverso il quale il Papa esercita il suo magistero ordinario, fornendo insegnamenti, direttive e chiarimenti su questioni di fede, morale, società e politica.
Le encicliche papali sono strumenti essenziali attraverso i quali il Papa comunica con l’intera Chiesa cattolica, fornendo insegnamenti autorevoli e direttive pastorali. Esse rappresentano una parte fondamentale del magistero pontificio e hanno un impatto significativo sulla vita dei cattolici e sulla società nel suo complesso.»
30 anni fa, il 25 marzo, festa della Annunciazione, Papa Giovanni Paolo II promulgava l’enciclica Evangelium Vitae. Possiamo pensare che sia l’espressione del grido lanciato nell’Omelia durante il Viaggio Apostolico negli Stati Uniti d’America, nella Santa Messa nel Capitoll Mall a Washington, domenica 7 ottobre 1979: «Quindi ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana è minacciata.
Quando il carattere sacro della vita prima della nascita viene attaccato, ci alzeremo in piedi per proclamare che nessuno ha il diritto di distruggere la vita prima della nascita.
Quando si parla di un bambino come un peso o lo si considera come mezzo per soddisfare un bisogno emozionale, ci alzeremo in piedi per insistere che ogni bambino è dono unico e irripetibile di Dio, che ha diritto ad una famiglia unita nell’amore.
Quando l’istituzione del matrimonio è abbandonata all’egoismo umano e ridotta ad un accordo temporaneo e condizionale che si può rescindere facilmente, ci alzeremo in piedi affermando l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Quando il valore della famiglia è minacciato da pressioni sociali ed economiche, ci alzeremo in piedi riaffermando che la famiglia è necessaria non solo per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune di ogni società, nazione e stato»
Tutta l’azione di questo grande e santo pontefice può essere letta come il suo alzarsi in piedi per annunciare la grandezza dell’insegnamento di Gesù, e la sua vittoria sul male e la menzogna.
L’inizio dell’Enciclica «Evangelium Vitae»
«Il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di Gesù. Accolto dalla Chiesa ogni giorno con amore, esso va annunciato con coraggiosa fedeltà come buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura… La Chiesa sa che questo Vangelo della vita, consegnatole dal suo Signore, ha un’eco profonda e persuasiva nel cuore di ogni persona, credente e anche non credente, perché esso, mentre ne supera infinitamente le attese, vi corrisponde in modo sorprendente. Pur tra difficoltà e incertezze, ogni uomo sinceramente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione e non senza il segreto influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta nel cuore (cf. Rm 2, 14-15) il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo termine, e ad affermare il diritto di ogni essere umano a vedere sommamente rispettato questo suo bene primario. Sul riconoscimento di tale diritto si fonda l’umana convivenza e la stessa comunità politica.»
E dobbiamo subito notare che questo Vangelo (che significa buona notizia) proprio perché si colloca nel campo della comunicazione, chi chiama in causa tutti gli uomini e chiede ai cristiani di essere testimoni.
Con una sottolineatura che non smetteremo mai di riproporre: l’orizzonte del cristianesimo è universale, Gesù ci ha raccomandato “andate in tutto il mondo e fate discepole tutte le genti”. È la libertà degli interlocutori che è in gioco e che può rifiutarsi ma non l’impegno a comunicare ciò che abbiamo incontrato.
L’annuncio cristiano si presenta come compimento dell’uomo: Il Concilio Vaticano II ci ricorda che solo nella luce del verbo incarnato trova luce e significato l’esistenza dell’uomo.
Siamo al servizio del Vangelo della Vita
«78. Così è anche quando si tratta di annunciare il Vangelo della vita, parte integrante del Vangelo che è Gesù Cristo. Di questo Vangelo noi siamo al servizio, sostenuti dalla consapevolezza di averlo ricevuto in dono e di essere inviati a proclamarlo a tutta l’umanità «fino agli estremi confini della terra» (At 1, 8). Nutriamo perciò umile e grata coscienza di essere il popolo della vita e per la vita e in tal modo ci presentiamo davanti a tutti.»
Vediamo ora alcuni passaggi fondamentali dell’insegnamento del Papa. C’è un aspetto fondamentale e decisivo che viene continuamente ricordato sia in molte parti dell’enciclica sia nel magistero ordinario di Giovanni Paolo II ed è il richiamo al fatto che il valore fondamentale dell’uomo, il suo essere persona, sta nell’essere voluto per se stesso.
Il valore della persona umana
“Come afferma il Concilio, l’uomo «in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stessa» (Gaudium et Spes, 24). La genesi dell’uomo non risponde soltanto alle leggi della biologia, bensì direttamente alla volontà creatrice di Dio: è la volontà che riguarda la genealogia dei figli e delle figlie delle famiglie umane. Dio «ha voluto» l’uomo sin dal principio – e Dio lo «vuole» in ogni concepimento e nascita umana. Dio «vuole» l’uomo come un essere simile a sé, come persona. Quest’uomo, ogni uomo, è creato da Dio «per se stesso». Ciò riguarda tutti, anche coloro che nascono con malattie o minorazioni. Nella costituzione personale di ognuno è inscritta la volontà di Dio, che vuole l’uomo finalizzato in un certo senso a se stesso. Dio consegna l’uomo a se stesso, affidandolo contemporaneamente alla famiglia e alla società, come loro compito. I genitori, davanti ad un nuovo essere umano, hanno, o dovrebbero avere, piena consapevolezza del fatto che Dio «vuole» quest’uomo «per se stesso».” (Lettera alle famiglie)
Quando si è persona umana?
«Sul riconoscimento di tale diritto si fonda l’umana convivenza e la stessa comunità politica.
Questo diritto devono, in modo particolare, difendere e promuovere i credenti in Cristo, consapevoli della meravigliosa verità ricordata dal Concilio Vaticano II: «Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo». In questo evento di salvezza, infatti, si rivela all’umanità non solo l’amore sconfinato di Dio che «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3, 16), ma anche il valore incomparabile di ogni persona umana.»
Quali sono le minacce alla vita umana?
«11. Ma la nostra attenzione intende concentrarsi, in particolare, su un altro genere di attentati, concernenti la vita nascente e terminale, che presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità per il fatto che tendono a perdere, nella coscienza collettiva, il carattere di «delitto» e ad assumere paradossalmente quello del «diritto», al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte dello Stato e la successiva esecuzione mediante l’intervento gratuito degli stessi operatori sanitari. Tali attentati colpiscono la vita umana in situazioni di massima precarietà, quando è priva di ogni capacità di difesa. Ancora più grave è il fatto che essi, in larga parte, sono consumati proprio all’interno e ad opera di quella famiglia che costitutivamente è invece chiamata ad essere «santuario della vita».
Come s’è potuta determinare una simile situazione? Occorre prendere in considerazione molteplici fattori. Sullo sfondo c’è una profonda crisi della cultura, che ingenera scetticismo sui fondamenti stessi del sapere e dell’etica e rende sempre più difficile cogliere con chiarezza il senso dell’uomo, dei suoi diritti e dei suoi doveri. A ciò si aggiungono le più diverse difficoltà esistenziali e relazionali, aggravate dalla realtà di una società.
(continua)
link per Radio Maria https://radiomaria.it/puntata/tavolo-pro-life-17-03-2025/